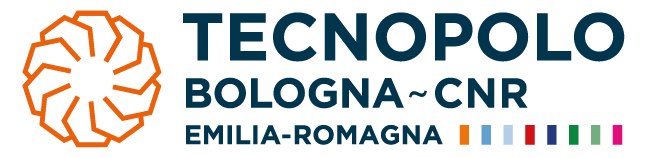20 Ott Le Terre Rare tra dipendenza economica e innovazione tecnologica: un approccio integrato
Le Terre Rare sono elementi indispensabili e critici per l’industria moderna. Utilizzate in settori strategici — dai catalizzatori ai magneti permanenti, dal vetro alla metallurgia, fino alle batterie e alle tecnologie emergenti come celle a combustibile e turbine eoliche — rappresentano una risorsa fondamentale per l’innovazione e la transizione ecologica.
Dal punto di vista scientifico, questi elementi non si trovano in natura allo stato nativo ma all’interno di pochi minerali primari, dai quali l’estrazione risulta complessa e costosa. Per questo, la ricerca sta lavorando intensamente su metodi alternativi di recupero e raffinazione, più sostenibili ed economicamente vantaggiosi.
A livello globale, le principali aree di estrazione si trovano in Nord America, Africa, Asia e Oceania. In Europa, le concentrazioni più significative sono localizzate in Scandinavia, mentre in Italia le zone più promettenti si trovano nel Lazio, in Sardegna e nella Sicilia meridionale.
🇮🇹 Tuttavia, il sistema industriale italiano presenta una forte dipendenza dalle importazioni di materie prime critiche, esponendosi così a rischi geopolitici importanti. Un’eventuale chiusura dei mercati da parte dei fornitori — come la Cina, che detiene una posizione dominante — potrebbe compromettere intere filiere produttive. Da qui nasce l’urgenza di sviluppare strategie nazionali e regionali per il recupero e il riciclo di questi materiali, creando anche nuove opportunità per le PMI e le start-up del settore.
In Emilia-Romagna, ad esempio, la strategia si fonda su due pilastri: la mappatura dei fabbisogni industriali e l’analisi dell’offerta locale, con l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità della filiera. La regione dipende completamente dalle importazioni per 12 minerali critici — tra cui cobalto, tungsteno, platino e Terre Rare — ma si sta distinguendo per lo sviluppo di tecnologie innovative di recupero, anche in ottica di economia circolare.
Un ruolo centrale è svolto dal mondo della ricerca, impegnato su due fronti: da un lato, minimizzare l’uso di elementi critici tramite metodologie alternative; dall’altro, riprogettare le filiere per sostituire materiali difficilmente reperibili con soluzioni più sostenibili.
Tra i casi più promettenti, la ricerca sull’utilizzo del grafene per l’estrazione delle Terre Rare da matrici acquose: un materiale che, grazie alla sua particolare struttura ossidata, mostra un’elevata affinità per gli ioni metallici. Filtri a grafene e derivati come il grafisulfone sono già impiegati con successo nella depurazione delle acque, dimostrando come l’innovazione scientifica possa avere applicazioni industriali concrete.
Nonostante i progressi, il riciclo delle Terre Rare rimane una sfida. In Italia, recuperarle dai RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è oggi più costoso che importarle. Il sistema di raccolta e gestione è ancora poco efficiente: l’Italia conta solo un centro di raccolta ogni 130.000 abitanti, contro 1 ogni 400 in Paesi come la Norvegia. Questa carenza infrastrutturale, unita a una scarsa consapevolezza diffusa, limita fortemente la capacità di recupero.
È evidente che la transizione verso un modello produttivo più sostenibile passa non solo dall’innovazione tecnologica, ma anche da politiche di sensibilizzazione, incentivi mirati e una collaborazione più stretta tra ricerca, istituzioni e industria.
Un evento denso di spunti e conoscenze, che ha permesso di esplorare a fondo un tema cruciale per il futuro della nostra economia e del pianeta.