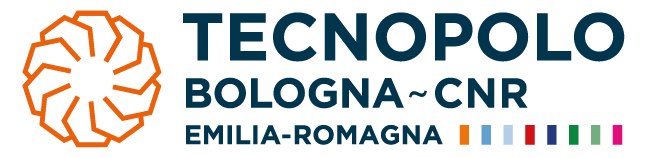28 Apr Donne e Scienza: le loro storie, la nostra sfida – Intervista a Giulia Migliori di INAF-IRA
In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, che si celebra l’11 febbraio, abbiamo intervistato 5 donne che lavorano nell’Area Territoriale di Ricerca CNR di Bologna. Il nostro obiettivo? Accendere i riflettori su una realtà che spesso passa inosservata o inascoltata: il divario di genere nel mondo della ricerca scientifica.
Vogliamo parlare di ostacoli invisibili, di leadership ancora troppo sbilanciata, di talenti che faticano a emergere non per mancanza di merito, ma per un sistema che non sempre gioca a favore delle donne. Dati e statistiche non sono troppo incoraggianti, ma la scienza non è fatta solo di numeri, è fatta di persone. Di donne che ogni giorno mettono talento, passione e competenza in un mondo che spesso non le riconosce abbastanza.
Vogliamo capire a fondo la situazione, analizzarla con dati e testimonianze, e soprattutto aprire un dialogo su come cambiare le cose. Abbiamo pubblicato un primo articolo per offrire una panoramica generale > se te lo sei perso, lo trovi qui.
Nei prossimi articoli lasciamo parlare le cinque donne, cinque storie diverse ma con un filo conduttore comune: la determinazione di andare oltre gli ostacoli e dimostrare che la scienza ha bisogno della loro voce. Il cambiamento è già in atto.
Intervista a Giulia Migliori, Ricercatrice INAF-IRA (Istituto Nazionale di Astrofisica – Istituto di Radioastronomia) presso l’Area della Ricerca Territoriale di Bologna CNR
Come si caratterizza la disparità di genere nella ricerca scientifica? e che conseguenze ha o rischia di avere sui percorsi formativi e professionali delle donne del settore?
MIGLIORI: Dal mio punto di vista, la ricerca scientifica condivide lo stesso peccato originale della gran parte del mondo del lavoro in generale e cioè che le donne vi sono entrate alle regole degli uomini. Questo assomiglia un pò a liberare un cassetto (magari quello più in basso e più piccolo) quando si inizia una convivenza, quando invece sarebbe da cambiare l’armadio intero se non l’abitazione. L’impatto è a tutti i livelli e il percorso per cambiare questa situazione è lungo, passa attraverso azioni concrete e un cambiamento di mentalità di tutti. Per fare un esempio, uno degli stereotipi di genere che ricorre spesso riguarda le capacità o meno di leadership delle donne, che in parte giustificherebbe la mancanza di donne nelle posizioni apicali. A parte il fatto che le ragioni siano probabilmente altre, e di natura anche molto pratica, forse da mettere in dubbio è il concetto di leadership per come è inteso ora, che corrisponde ad una visione che le donne non hanno neanche contribuito a formare.
Perché credi che sia necessario dedicare una giornata alla Donna, scienza e ragazze?
MIGLIORI: La giornata dedicata è utile, chiaramente solo se parte di un’azione continuativa, come momento nel quale fare il punto sui progressi fatti e su quanto rimane da fare (ancora tanto!). Inoltre, avere una giornata dedicata rappresenta l’occasione per una serie di iniziative con il pubblico in generale e le scuole in particolare. Queste sono importanti per sostenere un cambiamento che, per consolidarsi, deve andare oltre i confini del mondo della ricerca e partire dalle generazioni più giovani
Durante il tuo percorso nella scienza, hai mai considerato di cambiare strada a causa di ostacoli legati a stereotipi di genere o pressioni sociali?
MIGLIORI: I motivi per i quali mi è capitato di considerare alternative riguardavano le incertezze sul futuro lavorativo (altro problema della ricerca) e non coinvolgevano, personalmente, questioni di genere in maniera diretta. Ha contato molto anche il fatto di avere come supervisor e collaboratrici donne molto in gamba nella prima parte del percorso formativo.
Anche successivamente, i gruppi nei quali ho lavorato, all’estero e in Italia, sono state ottime esperienze.
Questo ha dipeso dalla sensibilità dei singoli individui ma anche dal fatto che si trattasse di istituti dove le donne erano già presenti a tutti i livelli, come nel caso del DAp (CEA-Saclay) in Francia e dell’IRA qui.
Tuttavia, di colleghe che si sono trovate a dover considerare se continuare nella ricerca e che hanno lasciato per l’impossibilità di conciliare la vita professionale e quella personale ne ho conosciute e purtroppo continuo a conoscerne. Dal mio punto di vista, non si può parlare di stessa libertà di scelta nel momento in cui la scelta di diventare o meno genitore ha un impatto tutt’ora totalmente diseguale per uomini e donne.
Su questo siamo ancora molto indietro e lo siamo sia nell’ambito della ricerca che come Paese.
Va sottolineato che ci sono azioni che possono contribuire a risolvere questo problema e il non intraprenderle corrisponde ad una volontà precisa.
Va anche ricordato che, sebbene importanti passi in avanti siano stati fatti, si tratta di conquiste e diritti acquisiti recentemente e non consolidati.
Per esempio, la rappresentanza di donne nelle posizioni apicali o il riconoscimento del loro ruolo nello sviluppo degli istituti nazionali è qualcosa che vediamo, con preoccupazione, ancora messa in discussione.
Qual è la frase più sessista e/o discriminatoria che hai sentito rivolgere a una professionista nell’ambito della ricerca scientifica? Se ti va, raccontaci un’esperienza che hai visto o vissuto.
MIGLIORI: Una collega, che si trovava all’estero, una volta mi raccontò di aver preso parte ad un panel incaricato di assegnare un budget per fellowships dedicate a donne. A parte la questione, tutt’ora aperta, che il basso numero di donne implica spesso un carico di lavoro assurdo per le poche presenti per garantire la rappresentanza di genere nelle commissioni, durante la discussione uno dei partecipanti propose di ridurre l’ammontare delle borse per ottenerne di più. Insomma, non si vedeva nulla di male a proporre che le donne fossero sottopagate.